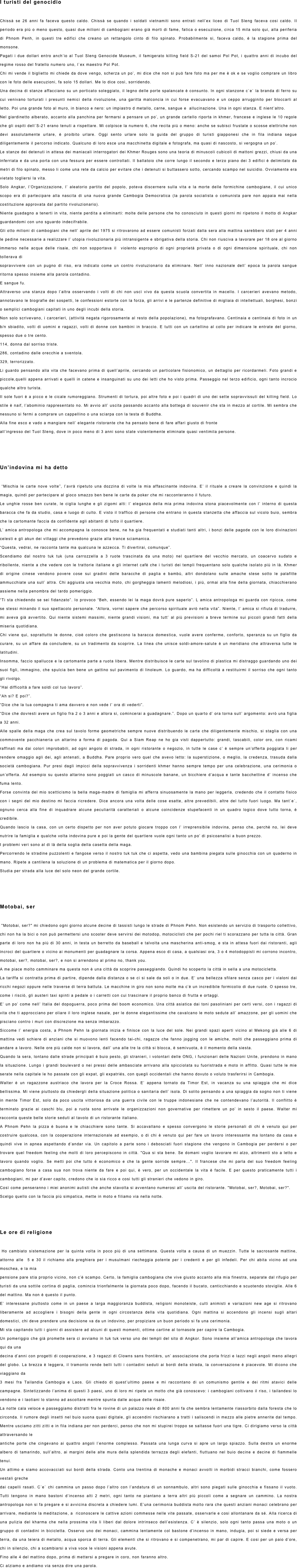




writings





Un accadimento qualsiasi (variante formicaio)
Una capanna d’assi approssimative è congelata in un pulviscolo denso, sfumato nella totalità dei toni. Il silenzio è infastidito da grilli metallici e cani lontani. Una squadrata proiezione luminosa invade l’ambiente staccandosi dal quadrato della porticina, del tutto spalancata sull’esterno accecante. Un tavolino vecchio, stantio, al centro dei 4 assi. Una bottiglia di vetro verde, macchiata di impronte di cemento irregolari, sta immobile sul bordo del tavolo. Un movimento tellurico, una sospensione di gravità, l’eco di un uragano, non importa: la bottiglia si abbatte su un lato. Dal collo consunto scende lento, come cascata tranquilla, un fiotto lungo di vino rosso, caldo. Sull’asse di caduta c’è un monticciolo di terra battuta, un foro buio che inghiotte e sputa formiche rosse e nere, minuscole o carnose, esagitate ma regolari. Trafficano la vita.
Il vino che cade, inutile accadimento entropico, inondando il formicaio crea rivoletti alcolici in cui le formiche annaspano disperate. Il caos, l’incoscienza del dolore. Quanti nutrimenti e morti e riproduzioni cancellate! La bottiglia è una botte da diluvio universale, generosamente terribile, non ha fine.
I grilli continuano, così i cani. La luce è la stessa, solo un po’ più decisa, comunque indifferente. Le formiche hanno smesso di lottare, sono una bandiera bianca forata di piombo.
Ora silenzio. Il regno è un pantano profumato di polvere e uva, sa quasi di morte.
Tutto ciò che non è donato va perduto
Il volontario è come una rockstar, riceve molto più di ciò che dà, Ne sei convinto?, Beh, noi seduciamo meno. Josè ci scarrozzava da un paio di giorni fra un ospedale e una scuola, la Fondazione in trent’anni ne aveva fatti di miracoli prosaici. Ma la mosca del cinismo ronzava imperterrita, rifiutavo il coinvolgimento incondizionato.
Lasciamo la strada principale ed imbocchiamo un sentiero che taglia la pianura sterminata: qualche campo di noccioline, l’unica cosa che qui la terra riesce a produrre, sporadici alberi rachitici e qualche contadino piegato su un aratro preistorico. Alcuni bambini scalzi ci rincorrono, si aggrappano alla ruota di scorta della jeep. Fingo di fotografarli e faccio le boccacce dietro il vetro rigato. Sai qual è la cosa straordinaria di questo posto?, Ce ne sono un bel po’ direi, Il fatto è che l’India è lì è pronta ad offrirsi all’ennesimo ingenuo che alla fine avrà solo accidente colorato, meraviglia transitoria, Sì e anche 45 gradi, fame e qualche cobra, Ok, ma ne vale la pena, dice Céline. Taceva pensierosa da quando avevamo lasciato la fattoria. Finisce di spolverare l’obiettivo e lo guarda in controluce. Andiamo in uno dei 1500 villaggi aiutati dalla ONG che stiamo filmando: si inaugurano undici nuove case, le prime in cemento. Sono poco più grandi di uno sgabuzzino, ma le mura di certo sono più resistenti agli elementi rispetto alle capanne di fango e paglia, impastate con gli escrementi e leggere come le efelidi.
Mi aspetto le borie delle inaugurazioni, il volontariato che avanza. I freni stridono, poco convinti, e ci fermiamo davanti a una folla in attesa. Apro lo sportello e un carnaio di persone mi viene incontro, tutta la comunità è lì ad accoglierci. Urlo un ciao sbruffone, giungo le mani per abbozzare un namasté. Due donne mi inghirlandano il collo con una spessa catena fatta di fiori e palle di plastica. Un’altra, più anziana, fa oscillare davanti agli occhi una bacinella d’acqua torbida, poi me la getta ai miei piedi e abbassa il capo. Scambio uno sguardo incredulo con Céline, Dove siamo finiti? Una mano, uscita dal mucchio colorato e ondeggiante mi disegna il terzo occhio in mezzo alla fronte, hennè rossa ruvida e ancestrale. Un turbinio di strette di mano, di come ti chiami? in un inglese insicuro, il tambureggiamento dionisiaco di alcuni vecchi invasati che percuotono asimmetricamente un cembalo di pelle di capra. Le due bacchette stantuffano in armonia con la terra avida e il calore abbacinante che appiattisce le forme e le volontà. Qualcuno porta degli ombrelli per ripararci dal sole. Céline fermati un attimo, sembri una Madonna, sorridi…Cerco di riprendere qualche immagine ma il corteo mi trascina lento verso la spianata con le case nuove, un serpentone avvolto in una nube rada di polvere rugginosa. I bambini si aggrappano ai pantaloni, cercano attenzione, lo sguardo radiografante, il sorriso incontaminato di chi ignora la malizia. Qualche donna al nostro passaggio si schermisce sull’uscio di una capanna, si sposta verso l’ombra generosa delle buganvillee, i gelsomini intrecciati nelle chiome oscillano come un pudore divertito. Io che ho sempre rigettato i panici coinvolgimenti di massa, qui non mi preoccupo di essere sbranato dai satiri dai cembali battenti e dalle baccanti fasciate dai sari morbidi. Mi sento un sorriso fra sorrisi. Sull’uscio della prima casa José, abituato a queste cerimonie gigioneggia con i nostri ospiti. Vieni, vieni, guarda ora. Rompe una noce di cocco su un sasso e mette le due parti su un tavolino, l’incenso brucia lento. Il battesimo delle nuove case inizia così. Un’immagine con un Cristo incorniciato da una moschea e dalla proboscide di Ganesh occhieggia a un palmo dal cocco ora intinto di terra rossa, la stessa che una mano sempre diversa continua a fissarmi sulla fronte e che il sudore continua a sciogliere. Céline è un puntino occidentale fra la folla che intasa il porticato di una casina accanto. Gocciolo come un panetto di burro, ho la faccia gialla come un clown itterico, i fiori della ghirlanda appassiscono. Josè Pablo mi tira a sé, Allora, per abbreviare la cerimonia segui uno di loro e vai a battezzare le case, Ma che dici, non è il caso, se poi si offendono, Vai, rilassati, li fai contenti, Ci vediamo dopo allora. Come sollevato dai contadini, fluttuo, non cammino, ma fluttuo, verso il mio rito inaspettato. Afferro la noce di cocco e ripetutamente la sbatto per terra, con attenzione però: i pezzi rotti dovranno essere due, tre sarebbero di cattivo auspicio, almeno Josè aveva capito così. Nell’altra mano ho la telecamera, continuo a essere indeciso se vivere o filmare, filtrare o immergermi. Uno, due, tre quattro colpi, il guscio cede. Il calore e l’esaltazione fanno scherzi percettivi, sento un piffero lontano che non incanta nessun cobra. Ce l’ ho fatta, gli uomini battono le mani, sorridono col movimento armonico del capo, mi mettono in mano un paio di forbici spuntate. Esattamente in questo istante, fra le tante cose che ci stanno in cielo e in terra, penso a quando un paio di anni prima, appena arrivato a Roma a cercar fortuna, lessi un annuncio per arruolare volontari da spedire in India, e pensai al raggiro o magari alla soluzione estrema per una vita parallela, e ora sono qui a scalfire noci di cocco in un villaggio di dalits. Taglio il nastro ed entro in casa, il cemento ancora fresco concede un po’ di estemporaneo refrigerio. Una coppietta di sposini, i beneficiati della casina, mi guardano di sottecchi, come se fossi un prete a Las Vegas durante una cerimonia, con rispetto ed un fondo di sospetto. Riesco sulla verandina, una bambina stretta in un’uniforme blu mi porge una noce di cocco e una cannuccia arancione, Drink father, e scappa correndo, quasi uno spot per analcolici. Il sole e la confusione sono accostati, allo zenit, mi guardo intorno per ritrovare gli altri. Josè si tira dietro la sua muta di marmocchi che pigola per avere qualche caramella, mi viene incontro con un sorriso criptico. Céline si siede accanto a me, sul muricciolo screpolato. Ma ti rendi conto che cosa è capitato in una mezz’ora?. Lei aveva preso in mano la telecamera e ora col bordo della maglietta toglie la polvere dall’obiettivo. Sai che una donna mi ha offerto sua figlia, per portamela via. Le guardo le mani, E tu che hai risposto?
La capanna del figaro
Manca un po’ d’acqua credo. Niente schiuma, la lametta raschia a difficoltà fra i capelli radi.
Si ferma come ad una scadenza, guarda allo specchio macchiato socchiudendo gli occhi per il gran calore, dondola la testa con un sorriso così. Sostituisce un’altra lama, la quarta. Io sto immobile, miope e sudato, in balia dei capricci balistici del mio figaro indiano.
La toilette sta procedendo bene, efficienza e esotismo da non credere. Dall’esterno strombazzi e muggiti come in una cacofonia sperimentale, scorci sonori della pianura sconfinata infuocata alle tre di pomeriggio. Facendo gesti scomposti allo specchio cerco di dirigere le traiettorie del taglio, ne va dei nei e del cuoio capelluto tutto. I due barbieri alle mie spalle danzano sommessamente la danza delle pennellate e delle sforbiciate, neanche si sfiorano in quest’ acrobazia giornaliera.
Lei mi osserva dall’uscio, in controluce, splendida a mezzo metro da me, una risata e una fotoricordo ad ogni smorfia esagerata. Neanche mi accorgo del mio vicino-cliente, solo qualche ondata di sudore e campagna quando scuote le mani davanti al volto, le mosche a succhiare saccarina dalla sua pelle grassa.
Il ventilatore puntato in faccia turbina come agonia di giri lenti e gommosi, praticamente inutile e quindi bello. Lo smog e il calore e i nostri odori e tutto, l’aria è un blocco di basalto trasparente. Spazzati via gli ultimi capelli mi toglie con scioltezza l’asciugamani sintetico e apre un tubetto di metallo, spremuto all’osso, color avorio. Sento un piacevole calore sulle guance. Mi ammorbidisco, mi sento quasi buono e nuovo. Movimenti maschi e circolari allargano due dita di cremina dopobarba: pizzicorii freschi sui micro-tagli e narici riempite di menta dolciastra, come il vaporub che da piccolo mi salvava dall’apnea. Stessa sensazione familiare e rassicurante.
Lei sta ancora seduta sullo gabellino che schiaccia la polvere dell’uscio, sorride sinuosa come una pesca. Offre noccioline a uno dei puttini scuri che oziano nella baracchetta lì accanto e poi li sorprende con le bolle di sapone che caccia dal mio zaino. Oh, e poi oh, e poi le vanno tutti sotto per accalappiare le bolle e annientarle e si fermano solo quando lei fa gli occhi duri. E’ un’arte, una dote maligna e un’arma, sono i geni a regalarti uno sguardo così, capace di dominare e asservire gli eventi. L’occhio come disegnato da Modigliani, florido e definito, di un verde marronato, controllava, controllava e decideva chi avrebbe meritato il suo raggio raggelante. I bambini si arrestano, non rifiatano neanche e tornano a spulciare le mucche e a lanciare sassi alle lucertole nei campi impotenti dietro la capanna del figaro.
Insomma attimo sospeso e ordine ristabilito, ma non per le nostre contrattazioni: in un inglese caricaturizzato e breve, servendoci di gesti universali e ammicchi incomprensibili, discutiamo a lungo sul prezzo del taglio a zero. La volontà di fondersi con i capricci del posto, di dare valore anche all’inutile, mi ha astratto dal mio ruolo di alieno a tempo determinato. L’avarizia gratuita e superflua è il contrappasso all’amabile gioco del ribasso e del rilancio su una cifra leggibile in due sensi. Le 20 rupie che mi chiede nell’economia della sua giornata sono 80 bidi croccanti, una corsa in risciò, un sacco di riso, qualcosa ecco. Per me sono una cifra da lanciare in una fontana pubblica per chiedere di ritornarci, il cambio di un gettone telefonico, nulla ecco. Tolgo i biglietti stropicciati dalla tasca e glieli porgo. Il barbiere oscilla soddisfatto il capo, è contento del suo lavoro e della pertinente maggiorazione di prezzo operata al turista di passaggio, amico immobile di una mezz’ora.




